La Società dei Profeti di Lorenzo Baravalle
Il 6 e il 9 agosto 2025 ricorrono gli ottant’anni dai bombardamenti atomici su Hiroshima e Nagasaki. Due date scolpite nella storia, che segnano l’inizio dell’period nucleare e la high quality della Seconda guerra mondiale, ma anche l’inizio di una riflessione mai conclusa sul rapporto tra scienza, potere e coscienza morale. A raccontare il lato meno noto di questa vicenda è il saggio La Società dei Profeti di Lorenzo Baravalle (Mondadori), autore noto per i suoi podcast dedicati alla storia, come Qui si fa l’Italia, Atomika e Fratre Mitra.
Baravalle sceglie di non concentrarsi sugli eventi bellici in sé – largamente documentati da libri, movie e documentari – ma di dare voce alle biografie di coloro che hanno reso possibile, in modi diversi e spesso contraddittori, la nascita dell’arma più distruttiva mai creata dall’uomo. Ne emerge un mosaico di scelte personali, dilemmi morali e visioni del mondo, che contribuisce a ridisegnare il profilo umano e intellettuale della scienza del Novecento.
Una rete di intelligenze europee nel cuore del progetto manhattan
Sebbene il Progetto Manhattan sia tradizionalmente associato agli Stati Uniti e al nome di Robert Oppenheimer, Baravalle mette al centro del suo racconto una dimensione spesso trascurata: quella europea. L’esodo forzato di scienziati, in fuga dai totalitarismi che infiammavano il continente, portò negli Stati Uniti alcune delle menti più brillanti della fisica moderna. Tra queste spiccano le determine di Enrico Fermi, Edoardo Amaldi e Klaus Fuchs, tre protagonisti che incarnano traiettorie divergenti ma profondamente significative.
Fermi, fisico italiano di genio precoce, ricevette il Nobel nel 1938 e lasciò l’Italia a causa delle leggi razziali, approdando negli Stati Uniti dove divenne una figura chiave del Progetto Manhattan. Fu lui a costruire la prima pila atomica e a compiere esperimenti che resero la bomba una realtà tecnica prima ancora che militare. Diverso il percorso del suo collega e amico Edoardo Amaldi, uno dei “ragazzi di by way of Panisperna”, che invece scelse di restare in Italia. Mentre il mondo si avviava verso la guerra totale, Amaldi preferì dedicarsi a una visione della scienza orientata alla tempo e alla cooperazione internazionale. Una scelta controcorrente, in un’epoca in cui tutto sembrava convergere verso la militarizzazione della conoscenza.
Ancora più controversa è la storia di Klaus Fuchs, fisico tedesco naturalizzato britannico che, pur lavorando al cuore del Progetto Manhattan, decise di consegnare i segreti della bomba atomica all’Unione Sovietica. Un gesto che, secondo le sue convinzioni, avrebbe contribuito a un equilibrio di potere e quindi alla tempo, ma che nei fatti accelerò l’inizio della Guerra fredda e divise il mondo in blocchi contrapposti.
Tra scoperta scientifica e responsabilità morale
Il libro di Baravalle cerca di ricostruire il contesto intellettuale ed emotivo in cui si muovevano questi scienziati. In un passaggio del prologo, l’autore sottolinea come due delle determine più emblematiche, Fermi e Fuchs, non abbiano lasciato testimonianze dirette del loro stato d’animo durante il Trinity Check, la prima esplosione nucleare della storia, avvenuta il 16 luglio 1945 nel deserto del New Mexico. Eppure entrambi erano lì, testimoni e protagonisti di un evento che cambiava per sempre il rapporto tra uomo e natura, tra sapere e potere.
Da un lato Fermi, descritto come gioviale e aperto al confronto, che contribuì in modo determinante alla riuscita del progetto. Dall’altro Fuchs, solitario e determinato, convinto che il suo gesto avrebbe impedito un dominio unilaterale della tecnologia atomica. Due visioni opposte, due uomini diversissimi, uniti dal fatto di aver inciso in profondità sul destino del mondo.
Edoardo Amaldi, il fisico che rifiutò la bomba
In questo intreccio di traiettorie individuali, spicca la figura poco conosciuta di Edoardo Amaldi, il “ragazzo che è rimasto”, come lo definisce Baravalle. Mentre colleghi e amici si trasferivano negli Stati Uniti, contribuendo alla nascita dell’arma atomica, Amaldi restò a Roma. Lo fece per proteggere il lavoro scientifico del gruppo di by way of Panisperna, ma anche per dare alla scienza una direzione diversa, più umana e civile.
Baravalle ne ricostruisce la biografia con attenzione e rispetto, facendo emergere la forza morale e l’impegno civile di uno scienziato che scelse deliberatamente di non partecipare alla corsa all’atomica. Amaldi fu tra i fondatori del CERN e promosse un’thought di ricerca scientifica fondata sulla collaborazione internazionale, anticipando molte delle questioni che oggi tornano con forza nel dibattito pubblico: il ruolo etico della scienza, la responsabilità degli scienziati, la necessità di bilanciare progresso e consapevolezza.
Un racconto che interroga il presente
Il merito principale de La Società dei Profeti sta nella capacità di trasformare una storia già nota – quella della bomba atomica – in una narrazione nuova, personale e collettiva allo stesso tempo. Baravalle si concentra sull’ambivalenza di scelte umane difficili, sulle tensioni tra destino individuale e responsabilità storica. Il suo racconto, pur basato su fonti verificate, ha l’andamento di una spy story, ma conserva la profondità di una riflessione etica.
Lungi dall’essere un semplice libro di storia della scienza o una biografia collettiva, il saggio si propone come uno strumento per interrogare il presente. Le storie di Fermi, Amaldi e Fuchs parlano infatti anche a noi, in un mondo nuovamente attraversato da tensioni geopolitiche e da dibattiti sul ruolo della tecnologia. L’period nucleare non è finita con Hiroshima e Nagasaki: continua sotto altre forme, più sottili ma non meno pericolose. Ed è proprio per questo che, a ottant’anni da quei giorni d’agosto del 1945, è necessario tornare a riflettere.
Baravalle ci invita a farlo senza retorica, attraverso le vite reali di chi ha costruito, rifiutato o tradito la bomba. E lo fa con uno stile rigoroso ma coinvolgente, che restituisce alla storia il suo volto umano.
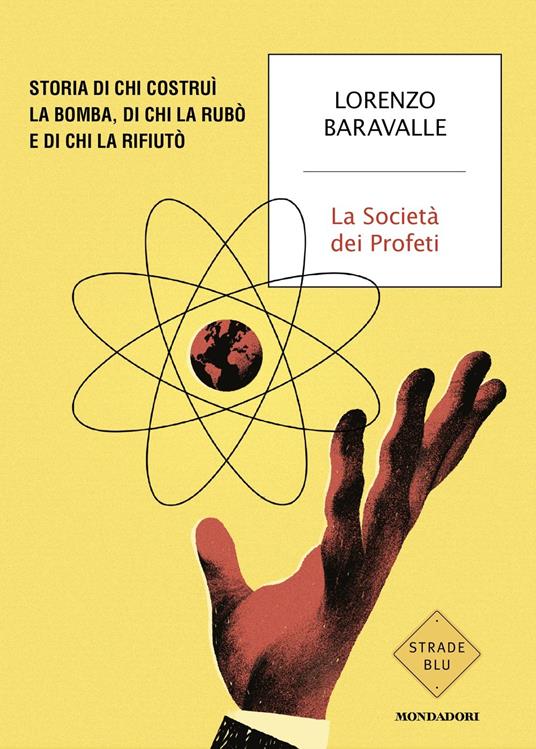
0 Comment